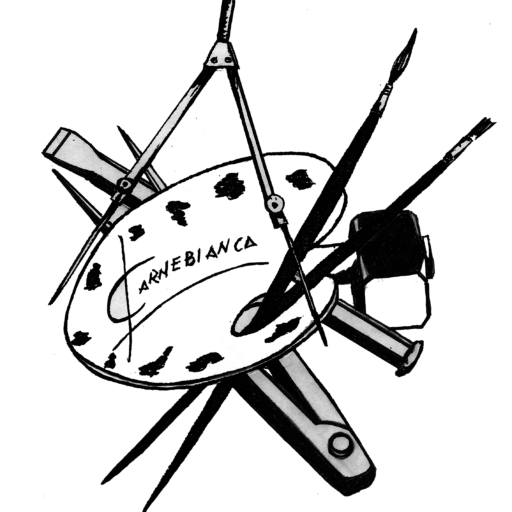Ho sempre avuto il sospetto, progressivamente fattosi convinzione sempre più radicata nella verifica dei testi e dei pronunciamenti teorici, che tutta la straordinaria sperimentazione nata dalla matrice delle protoavanguardie del nostro secolo non abbia in realtà soltanto spezzato una linea secolare di narrazione iconoplastica “chiusa”, né soltanto messo in crisi critica – secondo procedimenti ora ambiguamente e ironicamente soft ora brutalmente iconoclastici – la rappresentazione del reale fondata sulla mimesi, ma – ben più radicalmente – ricercato, sulle rovine di un senso che così a lungo aveva costituito una Consuetudine Sacra, le possibilità di un Nuovo Realismo. Non, si badi bene, di un altro realismo tra i tanti, o semplicemente di un realismo altro, un realismo autre, per riprendere una fortunata formula sessantesca; quanto piuttosto, credo, un Realismo Globale, non ristretto al contrasto anche duro nei confronti della cosiddetta “barriera del naturalismo”, e invece impegnato nell’ipotesi e nella pratica di una reinvenzione del mondo finalmente senza confini e senza remore, secondo una strategia di libertà formale e tecnica che non poteva non interrogarsi sulla funzione del fare estetico come produzione (ancora) mercificata di pulsioni e sogni e bisogni e utopie non esauribili, tenacemente gravide di futuro eppure segnate da una volontà di presenza attivamente problematica nel geroglifico oscuro del presente.
All’interno delle avanguardie visuali, in effetti, la costante della figuratività come convenzione del verosimile (ovviamente negata, quando non violentemente irrisa dai contesto) non è stata mai completamente cancellata. Esautorata sì, liquidata di tutto no. E questo fa semplicemente parte della drammatica e gloriosa storia dell’arte del Novecento. Ma quell’esigenza del Realismo Globale che nelle avanguardie è – secondo me – correttamente centrale, non si esaurisce nell’accettazione di un residuo mai fino in fondo bruciato di vita riconoscibile nella stragrande maggioranza dei loro prodotti. È nella tensione ad un mondo e a un’esistenza davvero alternativa a quella vigente e cogente: è, insomma, in ciò che il tardo Aragon si provava a definire con la formula di realismo congetturale. “L’aspirazione ad una società libera, in cui politica e cultura, ideologia ed estetica, agiscono insieme, ha subìto ancora una volta uno scacco”, scriveva nel 1970 Filiberto Menna (La regola e il caso, Ennesse Ed.). “Eppure, questi sono, continuano ad essere momenti decisivi per l’architetto, per l’artista, per l’intellettuale in genere: nonostante tutto, i fatti rimettono in gioco tutte le carte con spregiudicatezza estrema, con esuberante incautela”.
Com’è noto, il vecchio Hume, da onesto empirista, pone alla base della comprensione e dell’apprezzamento dell’opera d’arte le due costanti della novelty (novità) e della facility (agevolezza). Oggi, sottoposto ad un grado di conformizzazione enorme e di impigrimento progressivo (superficialità dell’informazione, centrali mass-mediatiche impegnate nella fabbrica del consenso diffuso, etc.), il pubblico aspira a prodotti estetici la cui facility sia plateale e la novelty possieda soprattutto caratteri di estrema decifrabilità. Di qui, la lucida considerazione di Dorfles (Le oscillazioni del gusto, Einaudi 1970), oggi più che mai valida e quanto mai pertinentemente applicabile alla congerie entropica del consumo artistico: “Dobbiamo (…) prender atto che la mente umana si pasce d’un immenso universo di segnalazioni e di stimolazioni – vuoi sonore che visuali e formali in genere – e che tali stimolazioni, tanto quelle “disinteressate” attribuite all’arte che quelle utilitarie dovute ad agenti non considerati di solito come artistici, hanno un’efficacia sulla germinazione di quelle costanti formative che dominarono sempre l’attività umana, e da cui poi traggono lo spunto le spanerse manifestazioni estetiche”.
Si tratta di elementi di riflessione che uno scultore come Enzo Carnebianca, impegnato a coniugare audacemente la regola e il caso non più secondo gli automatismi surrealisti ma all’interno di una griglia in cui certi stilemi surrealisti vengono stretti a un’esigenza pressante di realismo globale, riesce a incarnare nella sua quotidiana pratica di artista plastico e figurativo. La sua dimensione è quella dell’asimmetria violenta e della devianza feroce dai codici della compostezza più rassicurante. A un mondo capace soltanto di produrre distruzione, Carnebianca oppone il feticismo rovesciato e estremistico di una storia dell’uomo (e del suo corpo in primis) giunto alla sua epitome catastrofica. Esiti di pura negatività denunciati attraverso una grammatica del sogno che è spanentato puro incubo, messaggi crudamente contraddittori e “depressivi” rispetto all’ottimismo pubblicitario della società dello spettacolo e dei consumi, avvertenze aspre sul cannibalismo e l’autofagia del nostro mondo.
Il post-surrealismo di Carnebianca si snoda su un codice di opposizione e di dura intrattabilità, e l’angoscia che ne emana rimanda puntualmente alla condizione odierna dell’uomo umiliato e oppresso, in una sorta di ontologia plastica della tortura universale. “La poesia deve avere per scopo la verità pratica” ha affermato Lautréamont; e Breton (1935) ha scritto: “Nello stato di crisi attuale del mondo borghese, di giorno in giorno più cosciente della propria rovina, io credo che l’arte d’oggi debba giustificarsi come conseguenza logica dell’arte di ieri e al tempo stesso sottomettersi il più spesso possibile a un’attività di interpretazione che faccia esplodere nella società borghese il suo dissidio”. È chiaro che una premessa del genere mette in discussione anche la sfera della sintassi formale. In quel testo capitale che è Il Surrealismo e la Pittura, il leader del movimento scrive: “Una concezione troppo stretta dell’imitazione data come scopo all’arte, è all’origine del grave malinteso che si è andato perpetuando sino ai nostri giorni. Sulla fede che l’uomo non è capace che di riprodurre con più o meno felicità l’immagine di ciò che lo tocca, i pittori si sono mostrati troppo concilianti nella scelta dei loro modelli. L’errore commesso fu di pensare che il modello non poteva essere preso che nel mondo esteriore, o anche che ivi soltanto potesse essere preso. Certo la sensibilità umana può conferire all’oggetto dall’apparenza più “volgare” una distinzione del tutto imprevista; non è però meno vero che è fare un cattivo uso del potere magico della figurazione, di cui certuni posseggono il dono, servendosene per la conservazione e il rafforzamento di ciò che esisterebbe già anche senza di essi”.
È uno schiaffo alla stanca idolatria del verosimile e, al tempo stesso, un altolà a una pratica espressiva tentata dall’evasione.
Qualcosa che nell’opera di Carnebianca trova una risposta di grande libertà e di grande forza contemporanea proprio nel rilancio che lo scultore effettua di un’utopia non contemplativa ma attiva e protagonistica, tanto più necessaria quanto più le sue immagini emettono infelicità, impotenza e dolore. Questi idoli antropomorfi in posizione ieratica, questi fossili lucidi e levigati squarciati dalla violenza, scuoiati e scarnificati da orrori misteriosi, destinati a ospitare nel loro soma orologi enigmatici, pendoli-frutti, o a presentare fattezze zoomorfe (Sedia con serpente; Uomo elefante), o a ridursi a puri contenitori vuoti di pelle afflosciata (Le mute), esprimono un mondo dominato dalla costrizione, torto ad una prevaricazione innaturale e cieca. Ecco, il senso della cecità, dell’incompletezza dell’essere e della misura sottratta è soprattutto ciò che il perentorio onirismo espressionistico di Carnebianca comunica. E se lo sguardo dello scultore è lungamente diacronico, attraversando i continenti del mito e del simbolo, della storia remota e del raccoglimento fetale, dell’aspirazione cosmica e dell’urgenza sacrale, è poi superbamente capace di fissarsi in stringente allegoria visionaria del nostro oggi proprio in forza dell’energia dinamica che fa vibrare le sue impeccabili volumetrie di slanci inconsueti, di fratture sorprendenti, di attese rivelatrici. I più attenti critici dello scultore romano, da Vivaldi a Apuleo, da Civello a Bellezza, da Calabrese a Tallarico a Riviello a Selvaggi a Domenico Guzzi a Mercuri, lo hanno del resto sottolineato con la dovuta puntualità.
Vivaldi ha parlato a suo tempo di Carnebianca come di uno “scultore nato” dotato di un “plasticismo assai sottile e nello stesso tempo vigoroso”. Una scultura, quella di Carnebianca, in cui si afferma una misura dello spazio esatta, un modellato pungente e linearmente molto duttile, un’eleganza di stilizzazione che fa pensare agli esempi liberty di un Wildt, una simbologia surrealista assai originalmente risolta in cadenza e ritmi aerei e danzanti, senza che la sua drammaticità abbia niente di eccessivo. “Riviello aveva già parlato di linea genetica della sua ricerca, e Civello aveva insistito sulla forza d’urto” che finisce con l’essere il magma connettivo di tutte le realizzazioni “enucleando” il “surreale atipico” dell’artista.
La metafora di un mondo che cova in sé l’uovo di serpente della propria perdizione e del proprio svuotamento (di materia e di senso) risulta nella scultura di Carnebianca – e in spanersa ma coerente misura nella sua opera pittorica, o nei suoi elegantissimi e crudeli gioielli – un viaggio nell’orrore e nel nulla compiuto con una sorta di stupore geometrico attraverso luoghi in cui abitano senza incontrarsi attesa e afflizione, gremito di agguati e di misteriose, inquietanti presenze. Così, quello dell’artista romano si sviluppa come un transito cosmologico e irreale, ierofanico e ritualistico in un grumo di materia atrocemente lacerata e scissa. È in questa ricchissima ambiguità che il surrealismo espressionistico di Carnebianca conquista con nitida sicurezza formale la sigla di una poesia magica e feroce, e che le sue spietate pulsioni si determinano in modi al tempo stesso impassibili e implacabili.
Accademia Platonica, maggio 1994
Mario Lunetta